 a cura di Luciano Giustini
a cura di Luciano Giustini
Installazione di un Point (seconda parte)
di Luciano Giustini Avete letto l'articolo della volta scorsa? Si? Era piuttosto introduttivo, lo ammetto, ma vi erano spiegate due o tre cose che costituiscono poi la base del perfetto neo-Point ... Scherzi a parte, non mi dilungheró ulteriormente sulla suddivisione dei programmi, ricordando che per poter installare un Point in una rete in tecnologia Fidonet servono:
 un mailer (programma che chiama il boss e prende/manda la posta)
un mailer (programma che chiama il boss e prende/manda la posta)
 un mail processor (programma che smista/scandisce la posta nella base messaggi)
un mail processor (programma che smista/scandisce la posta nella base messaggi)
 un editor (programma che permette la lettura/scrittura, off-line, della posta)
un editor (programma che permette la lettura/scrittura, off-line, della posta)
Ricordo, se ce ne fosse bisogno, che stiamo parlando del mondo shareware/freeware, non dimenticate che di commerciale in questa rubrica non sentirete mai parlare (o almeno spero).
La scelta dei programmi per il Point deve basarsi essenzialmente su due fattori: il sistema operativo che usate (o che usate per il maggior tempo) e il tipo di base messaggi in cui vorrete tenere la posta. La seconda scelta in realtá è molto piú semplice della prima, in quanto ormai le basi piú usate sono rispettivamente la squish (in assoluto la piú diffusa) e la jam, un tantino piú veloce. La base squish deve il suo successo anche a uno dei piú famosi e diffusi tosser, "Squish" appunto, freeware, giunto alla release 1.11 e provato nel numero scorso di BETA. Tenete presente che non tutti i programmi esistono per tutti i sistemi operativi, con l'eccezione del DOS, per cui c'è tutto o quasi; e con l'eccezione di un mailer, "BinkleyTerm", in versone nativa per ben 3 piattaforme senza cambiamenti (DOS, OS/2, Windows NT). Un altro mailer c'è sia per DOS che per OS/2, "Xenia" ora giunto alla release 1.98, mentre per il lato tosser abbiamo Squish per DOS e per OS/2.
Gli editor sono stati scritti un pó per tutte le piattaforme, e per DOS il piú diffuso (e veloce) è sicuramente "GoldED", seguito a ruota da SemPoint per Windows provato nel numero scorso di BETA, e da "FleetStreet" per OS/2 PM. Difficile dire quale sia il migliore tra questi tre best-seller, ognuno di essi propone soluzioni ad hoc per il sistema operativo per cui è destinato. GoldEd per esempio predilige la velocitá se eseguito con il suo extender DOS a 32 bit; SemPoint sfrutta la grafica di Windows per le impostazioni, la visualizzazione, i colori, dimensionamento, ecc.; FleetStreet sfrutta il multithreading di OS/2 per tenere attive piú finestre sulla stessa scena di lettura, ecc.
INSTALLAZIONE
Per l'installazione dei programmi sceglieremo una organizzazione delle directory adeguata, ad albero per quanto riguarda la
sistemazione dei programmi e della base messaggi, e tutto sotto un'unica subdirectory per una facile "manutenibilitá". Il mio
consiglio, se adottate sistemi operativi evoluti, è di porre tutto in una partizione sempre visibile sul vostro hard disk, specialmente se
formattate un'altra o le altre partizioni in file system diversi dalla FAT; in questo modo, se avrete dei problemi su queste ultime, non
dovrete ricominciare a configurare di nuovo tutto. Se state sotto OS/2, è conveniente disabilitare la variabile di ambiente DELDIR per
la partizione in cui risiede la base messaggi; essa infatti tiene traccia di tutti i file cancellati (per permetterne il recupero) e rallenta
discretamente le operazioni di tossing.La scelta dei programmi per questo nostro viaggio potrá scatenare guerre di religione, ma non è affatto necessario: viene infatti dettata solo dalla disponibilitá dei programmi per piú piattaforme, e quindi per poter raggiungere un maggior numero di potenziali utenti (oltre che per poter portare il proprio Point da un sistema operativo all'altro cambiando solo gli eseguibili). Partiamo quindi con l'accoppiata Binkleyterm + Squish. Per il primo rimando la palla all'articolo di Cesare tensi su questo stesso numero, mentre per Squish ne parliamo ora.
Squish
Squish si appoggia sui file SQUISH.CFG e ROUTE.CFG, entrambi in formato testo, forniti in una configurazione di default e commentati, insieme al pacchetto. Il primo è il piú corposo e anche il piú importante, contiene gli indirizzi, le aree, ecc. e che vediamo adesso come configurare correttamente, usandone uno giá impostato per 2 net (Fidonet e Caesarnet). I miei commenti sono in neretto. Ricordo che tutte le keyword che non appaiono nell'elenco che segue sono intese commentate.SQUISH.CFG
Address 2:333/201.2010
Address 175:391/1.5
Address 2:335/336.26
qui specifichiamo i nostri indirizzi in rete (in questo caso tre indirizzi per due reti)
NetFile C:\COMM\INBOUND
questa è la directory dei file in arrivo (posta, file request, ecc.)
;AreasBBS Areas.BBS
questa keyword è commentata (disabilitata), e dice a Squish dove eventualmente leggere il file di aree. Ricordate che
lo standard areas.bbs non prevede il multi-aka (also known as, indirizzi diversi) con zone differenti.
;BinkPoint
controversa keyword, in realtá andrebbe abilitata (ricordo che nel nostro point di esempio stiamo usando Binkleyterm
come mailer), ma contro ogni logica spiegazione pare creare meno problemi se è disabilitata. In caso di dubbi, non
resta che provare.
Compress Compress.Cfg
; For most people, the default COMPRESS.CFG is all that is required.
il commento dell'autore mi sembra esauriente. Solo nel caso della versione per OS/2, nel file COMPRESS.CFG vanno
apportate le seguenti modifiche alla voce ZIP:
; Phil Katz's PKZip
Archiver ZIP
Extension ZIP
Ident 0,504b0304 ; "PK^c^d"
Add zip -k -9 -j %a %f
Extract unzip -j %a %f
View zip -v %a
;End Archiver
Routing Route.Cfg
di questo file parleremo piú tardi
OUTBOUND C:\COMM\OUTBOUND
questa è la directory (in realtá diventa un insieme di directory) dove vengono depositati i pacchetti in uscita dal nostro
sistema
Quelle che seguono sono keyword a scelta dell'utente (e per la cui descrizione rimando al commento dell'autore) e
poco importanti ai fini del funzionamento del Point
CheckZones
Duplicates 1000
DupeCheck Header MSGID
LogFile Squish.Log
LogLevel 6
LinkMsgId
QuietArc
KillDupes
KillBlank
SaveControlInfo
Statistics Squish.STT
Swap C:\Temp\$$SQUISH.SWP
Buffers Large
TossBadMsgs
;Password 175:391/1 xxxxxxxx
ecco un'altra keyword controversa. Di primo acchito verrebbe spontaneo segnare i giusti valori, eppure vi assicuro che
anche commentata (come è ora) funziona tutto ugualmente.
; The official FidoNet standard for mail compression is ARC.
DefaultPacker ZIP
In realtá il compattatore ormai piu' usato in Fidonet (e anche in altri net) è il Pkzip, o comunque non certo l'ARC.
ForwardFrom World
ForwardFrom File All:All
due keyword utili per un sistema BBS, meno per un Point
Definiamo le aree di posta privata (matrix, o Netmail) distinte per i due net, e opzionalmente le aree di messaggi in bad
e i duplicati
NetArea NETMAIL2 C:\COMM\MAIL\NETMAIL\NETMAIL -$ -h
NetArea NETMAIL175 C:\COMM\MAIL\NETMAIL\NETM175 -$ -h -p175:391/1
BadArea BADMSGS C:\COMM\MAIL\BADMSGS -$
DupeArea DUPEMSGS C:\COMM\MAIL\DUPEMSGS -$
Quello che segue è un elenco delle varie aree echomail definite in questo esempio per 2 net diversi. Rimando al commento originale dell'autore per la definizione esatta delle keyword ausiliarie. Ricordo inoltre che queste definizioni non servono se si usa il file areas.bbs
; FIDONET - 2:333/201
EchoArea 2MANO.ITA C:\COMM\MAIL\FIDONET\2MANOITA -$ -p2:333/201.2010 2:333/201
EchoArea OS2_DEV.ITA C:\COMM\MAIL\FIDONET\OS2DEV -$ -p2:333/201.2010 2:333/201
; FIDONET - 2:335/336
EchoArea 2MANO.300 C:\COMM\MAIL\FIDONET\2MANO300 -$m500 -p2:335/336.26 2:335/336
; CAESARNET - 175:391/1
EchoArea AFORISMI.I C:\COMM\MAIL\CAESAR\AFORISMI -$ -p175:391/1.5 175:391/1
EchoArea CHATTER.I C:\COMM\MAIL\CAESAR\CHATTER -$ -p175:391/1.5 175:391/1
EchoArea BTA_ARTE C:\COMM\MAIL\CAESAR\BTAARTE -$ -p175:391/1.5 175:391/1
EchoArea HARDWARE.I C:\COMM\MAIL\CAESAR\HARDWARE -$ -p175:391/1.5 175:391/1
notate che alla fine del path e dopo la definizione di tipo di base ("-$", che sta per squish) compare la keyword "-p"
seguita dall'indirizzo 4D (point) e da quello del nostro boss: solo cosi' Squish saprá gestire correttamente questo che
viene chiamato il multi-aka
; END OF FILE
ROUTE.CFG
La logica di questo file di configurazione (del tutto simile a quella di altri file "fratelli") è quella di stabilire dove e per chi mandare i nostri pacchetti di posta nel momento in cui li inviamo fino a quando arriveranno a destinazione. La sintassi per il route, in particolar modo, corrisponde a un "manda per questo_nodo tutti i messaggi per questo_indirizzo" ed è molto utile (se non indispensabile) per i casi di multi-aka come nel nostro esempio.
Send Crash 2:335/336
Send Crash 2:333/201
Send Crash 175:391/1
abbiamo appena definito a chi mandare i nostri pacchetti posta: gli indirizzi del/i nostro/i boss.
Route Crash 2:333/201 2:334/All
Route Crash 2:333/201 2:333/All
Route Crash 2:335/336 1:All 2:All 3:All 4:All 5:All 6:All
ora abbiamo definito la logica di routing a cui deve sottostare Squish per le aree Fidonet: a partire dalla prima riga abbiamo detto che i messaggi per il net 334 (il "all" equivale a dire "tutti" nel pezzo di nodo che si sostituisce, nel nostro caso tutti gli hub del net 334) devono passare per il 2:333/201, in modo Crash, ovvero per chiamata diretta. La stessa cosa per la seconda linea, mentre nella terza abbiamo lasciato tutto il resto nelle..mani del boss 335/336. Attenzione a rispettare l'ordine in cui vengono prima le eccezioni rispetto al routing principale (piu' generale), in questo caso appunto i messaggi del nodo 2:333/201 rispetto a quelli del nodo 2:335/336.
Route Crash 175:391/1 175:All
Route Crash 175:391/1 200:All
qui è la stessa cosa detta finora, applicata al secondo network di cui siamo Point.
; END OF FILE
Per questa volta è tutto. Leggete ora l'articolo su BinkleyTerm di Cesare Tensi e..ci vediamo nel prossimo numero di BETA!
- fine seconda parte -
[ Sommario | Redazione | Informazioni | Vai a... ]
xxxx:yyyy/zzzz.wwwww
Per maggiori informazioni sia sulla nascita di Fidonet, e parimenti quella delle altri reti amatoriali, che su come sia strutturato la
costruzione di un numero di nodo, vedere l'articolo "Un approccio a Fidonet" nel numero precedente di BETA.
Come è stato detto per diventare point di una BBS bisogna prima di tutto contattare il sysop (d'ora in poi chiamato Boss per semplicitá
di discorso) al quale si vuole fare riferimento come messaggistica e/o file. Il sysop è un punto di riferimento costante, che dipana
eventuali dubbi, che aiuta nei momenti di difficoltá del point, aiutandolo nelle varie configurazioni di tutto.
Ma dato che c'è stata una enorme produzione di software che permette l'uso di una tecnologia "point" certe volte anche lo stesso
sysop incontra qualche difficoltá a capire bene il funzionamento concettuale di un determinato programma che usa un point (ma
basilarmente sono tre i programmi fondamentali), quindi molte volte capita che non riesce a risolvere problemi incontrati
dall'installazione del software. Quindi da qui inizio, in collaborazione con Luciano Giustini nella stessa rubrica Telematica, una piccola
descrizione sia dei software a disposizione dei point (e anche dei Boss, perchè no?) che della loro installazione corretta, cercando di
dipanare tutti quei dubbi, tutti quei problemi che gli stessi point della mia BBS incontrano nel momento di installarli. Parleró quindi di
tre software "principi" per un point che abbia un PC IBM compatibile, sia che abbia il sistema DOS che OS/2, il sistema operativo che
finalmente consente un vero multitask nel PC di casa senza avere una macchina molto potente.
I quattro (tre se non si hanno connessioni particolari, cioè appartenere a piú reti) software principi sono i seguenti:
BinkleyTerm v.2.59a.
Come potrete notare quando, eventualmente, scompatterete i file compressi, tutti e tre i programmi hanno come file di configurazione
dei file di testo, cioè nulla di configurabile via finestre, opzioni, bottoni e cosi' via (come ci ha abituato la programmazione con il Turbo
Vision). E vi chiederete il perchè. Io posso azzardare una risposta: certe volte i file di testo, che configurino un programma complesso
o meno, sono piu' "leggibili" di tutte le altri tipi di configurazione, perchè permettono principalmente di leggere il testo riga per riga e
modificare le varie keyword (o metacomandi) con valori opportuni limitando al minimo la possibilitá di errore o malconfigurazione.
Questo è una cosa normale sia sotto DOS che OS/2 o Unix, dove tutti i file di configurazione (che hanno una estensione comune:
*.CFG) sono file di testo. Certamente è una configurazione piú lunga, piú complessa, per vari motivi. Ma state certi che una volta che
siete arrivati alla fine, e se avete messo i valori giusti, tutto funzionerá senza alcun problema. E' una mia idea, io preferisco programmi
che possono essere configurati in questo modo che tutte quelle finestre dove molte volte si dimentica qualche cosa con qualche
malfunzionamento...
Tutti e quattro i software sono disponibili sia per DOS che per OS/2 (BinkleyTerm anche per Windows NT), quindi hanno un ampio
parco macchine a disposizione, non credo che ci possano essere problemi (ho intenzione comunque di realizzare un articolo che
spieghi come installare un point anche sotto Macintosh) sia a un loro eventuale reperimento che del loro uso. Una volta configurati al
meglio si avrá un point funzionante al 100% e cosi' potrete utilizzare la rete Fidonet senza alcun problema...
Per un point sotto il sistema operativo DOS, c'è prima da installare un fossil che rimando, per la sua comprensione, a un altro articolo
nella stessa rivista.
Qui di seguito un tipico file di configurazione, standard, che puó spiegare alla perfezione come funzionano tutti le varie keyword che
possono essere usate dai point, il Normal le keyword di BinkleyTerm, in Bold (grassetto) il commento, le parti precedute dal punto e
virgola non hanno significato all'interno del file di configurazione e vengono ignorate da Binkley:
; BINKLEY.CFG - Configuration File for BinkleyTerm 2.50.
; MODEM AND DIAL SETTINGS
Port 1
Baud 19200
Carrier 80
Lockbaud
; LockBaud /ARQ
; AutoBaud
NoARQ /None
TermInit AT E1H0S0=0|
Prefix ATDT
; Suffix
Answer ATA|
PreDial `
Janusbaud 2400
StartBlkLen 8024
; DISK SETTINGS
Qui di seguito si configurano le directory di sistema.
StatusLog D:\Bink\log\BT01.log
Nodelist D:\Bink\nodelist\
Version7
NetFile D:\Inbound\
NetFile: pacchetti posta.
Hold D:\Outbound\
Snoop \PIPE\LINE1
;MAILER SETTINGS
System MICS OS/2 Forum #1 [HFN]
Sysop Michael Buenter
Domain fidonet fidonet nodex
Domain virnet virnet nodex
MyLocation Emmenbruecke CH
Bene, a questo punto se avete seguito tutte le istruzioni BinkleyTerm sará perfettamente funzionante. Una prova scioglierá tutti i
dubbi. Vi rimando al prossimo numero per la trattazione dell'editor dei messaggi, cioè di quel programma che consente la lettura dei
messaggi appena importati con BinkleyTerm e processati dallo Squish.
Al prossimo mese!
[ Sommario | Redazione | Informazioni | Vai a... ]
 a cura di Luciano Giustini
a cura di Luciano Giustini
BinkleyTerm, configurazione
di Cesare Tensi
Nel numero precedente della rivista è stato introdotto il concetto di point e della struttura tecnica della rete Fidonet (e di tutte le reti
che rispondono alle specifiche techiche della rete stessa). Per una migliore comprensione dell'argomento ne vado a riprendere alcuni
concetti. Un point è nello stesso tempo sia un utente di una BBS amatoriale, come lo puó essere una associata alla rete Fidonet, che
un nodo vero e proprio ovvero "speciale". Infatti, a un point è concesso d'ufficio, dal sysop della BBS di qui il point fa parte, un numero
di nodo "reale" nella rete Fidonet a cui in modo univoco corrisponde quella determinata persona (un pó come il vostro nome e la via in
cui abitate) in un formato che puó essere assimilato al seguente:
Squish v.1.11
GoldED v.2.50.Beta5
Compilatore di Nodelist, normalmente FastLst, di produzione italiana (v.1.20)BinkleyTerm, configurazione
Dopo l'introduzione di rito, passiamo a vedere una tipica configurazione di BinkleyTerm, cioè quel software che permette la
connessione con il Boss, usando la linea telefonica, per spedire/ricevere posta (cioè trasmettere la posta che si è scritta e ricevere la
posta nuova). BinkleyTerm è un programma strutturato a caratteri e che occupa l'intero monitor (Fig.1), se si vuole si puó differenziare
ogni singola finestrella specificando un colore diverso (è quasi sempre possibile).
Rappresenta il numero della porta, fisica, della seriale, quindi 1=COM1, 2=COM2, 3=COM3 ecc.
Va inserito la massima velocitá supportata dal modem. Normalmente, anche con un 28.8Kbps (V.34), che rappresenta
l'ultimo standard delle comunicazioni asincrone via rete telefonica commutata, consiglio il valore di 38400, poichè la
totalitá dei files che saranno trasmessi sarannó giá compressi all'origine quindi è perfettamente inutile sovraccaricare il
sistema impostando una velocitá della seriale superiore ai 38400.
E' un valore standard. va lasciato cosi'.
Blocca la porta al valore prefissato dal comando Baud. In parole semplici, la seriale avrá sempre la velocitá massima e
non si adatterá alla velocita della linea (cioè ad esempio: 14.4Kps se chiamate un modem che supporti il V.32bis,
eccetera).
Limita, con opportune chiavi, il bloccaggio della porta. In questo caso, solamente se i due modem colloquiano con la
correzione d'errore (v42bis e/o MNP5).
Imposta automaticamente la velocitá della porta seriale attraverso opportuni valori indicati nella nodelist, l'elenco
telefonico delle BBS in formato testo.
NoARQ /V32/None
Init ATZ0E0H0&K4#P4141538627|
La stringa di inizializzazione del modem. Non c'e' una stringa univoca per tutti i modem. La piu' semplice è la
seguente: ATZX3|. Il carattere "|" lo si ottiene con la successione Shift+"\" e rappresenta il "carriage return". Ricordatevi
che la totalitá dei modem provenienti dall'America e piu' in generale dall'estero, o comunque non omologati in Italia,
non riconoscono il tono di libero e quello di occupato delle centrali telefoniche italiane e quindi per evitare che il
modem abbia qualche problema (del tipo "NO DIALTONE") bisogna inserire, nella stringa di inizializzazione, X3.
La stringa con il quale il programma pone fine alla comunicazione e/o alla terminazione dello stesso.
Va inserito il modo con il quale il modem chiama un numero, ATDT= usa i toni (per le centrali digitali), ATDP= usa gli
impulsi (per le centrali elettromeccaniche, oramai presenti solamente in piccoli centri).
Busy ATS0=0|
La stringa con il quale il modem viene re-impostato ai valori di default quando il Boss è occupato.
Questo parametro è ininfluente per un Point. Imposta la stringa quando il modem riceve una chiamata. E' preferibile
che sia il programma (in questo caso BinkleyTerm) a rispondere ad un eventuale chiamata e non il modem stesso
(alzando il DTR) poichè in eventualitá di blocco del computer non c'è risposta e quindi spreco di scatti da parte del
chiamante.
PreInit |v`^`
Impostazioni standard. Non vanno modificati.
JanusOK /Arq/V32
JanusOK /V32
Queste impostazioni servono per abilitare il protocollo bidirezionale Janus (una specie di HS-Link, piú prestante), molto
comodo poichè permette, nello stesso periodo, di spedire e ricevere posta quindi con un minore tempo di
collegamento. Il valore da inserire dopo la key JanusBaud è il valore minimo di velocitá (in questo caso 2400) dopo il
quale il protocollo janus è abilitato. Chiaramente deve essere una cosa reciproca, cioè anche il vostro boss lo deve
aver abilitato.
Il Log di BinkleyTerm. In questo file vengono registrate tutte le chiamate che si effettuano.
La directory dove il programma puó trovare la Nodelist compilata.
Il numero di versione della nodelist compilata. V7 è l'ultima release, la piu' efficente.
KnownInbound D:\Inbound\
ProtInbound D:\Inbound\
Le tre sottodirectory dove BinkleyTerm pone i file che si ricevono. Piu' precisamente:
KnowInbound: directory dove vengono registrati i file provenienti da sessioni conosciute, cioè transazioni con
nodi in Nodelist
ProtInbound: directory, invece, configurata per nodi con password. Normalmente il Boss è configurato con
Password, per limitare al minimo "intrusioni".
Dove BinkleyTerm puó trovare i pacchetti di posta da spedire.
Questa keyword funziona solamente se il programma è funzionante sotto OS/2. Configura la pipe del programma
stesso, cioè su quale canale Binkleyterm puó comunicare il log. Normalmente la PipeLine è utilizzata al di sotto di una
LAN dove potrebbe essere impossibile seguire direttamente il computer dove viene eseguito il programma, la pipe
consente di avere sotto controllo tutte le operazioni.
Nome del sistema.
Nome del Sysop. Normalmente si mette il nome reale, per un corretto rispetto.
Questa keyword è legata al programma di compilazione della Nodelist, al nome della directory nel quale Binkley puó
trovare i pacchetti posta da spedire e al domain della rete. In questo modo: Domain Domain sottodir Nome_nodelist_Compilata
Address 2:335/336.3@fidonet
Configurazione del proprio numero di point. Inserito nel modo usuale, con chiocciolina e domain. Infatti il mailer lavora
fino a cinque dimensioni, avendo sotto controllo fino al domain (Fidonet, Virnet etc),.
Address 9:395/212.2@irnet
Come si puó vedere per una corretta configurazione, prima deve essere specificato il Domain e appresso il numero di
point. In questo modo si possono configurare fino a 10 AKA (Also Know As) diversi, magari per un sistema multi-point.
MyPhone 41-41-538627
MyListFlags CM,XA,V32B,V42B,FAX,OS/2
MyMaxBaud 14400
Queste servono esclusivamente per farsi riconoscere dal proprio Boss o al sistema al quale si sta chiamando.
BETA - la rivista ipertestuale tecnica, copyright © 1994-95
Luciano Giustini e Fernando Carello. Tutti i diritti riservati.
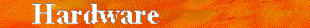 a cura di Fernando Carello
a cura di Fernando Carello