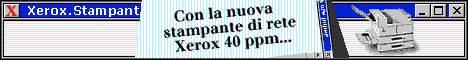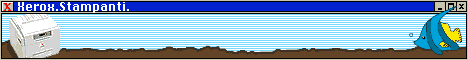|
 |

Sommario
Internet ID
Indici di BETA
Redazione
Mailing list
Installazione
Mirror ufficiali
Licenza Pubbl. Beta
Cerca
Stampa
|
 |
 |
 |
 |
Alcune novità fra le CPU e gli HD
Vediamo più da vicino il K6-2 di AMD con le sue nuove istruzioni 3DNow!
e le proposte economiche di Intel, Celeron e il chipset 440EX. Facciamo inoltre
una panoramica fra le novità di fascia alta fra i dischi IDE.
di Andrea Nenni
Articolista Senior, BETA
Fra i microprocessori, oltre al consueto velocissimo
ricambio imposto da Intel, stiamo assistendo a una spiccata diversificazione, spinta
direttamente dal mercato; il K6-2 e il Celeron rappresentano pienamente questo trend.
AMD K6-2
Dopo il buon successo del K6, ecco adesso il nuovo K6-2, noto precedentemente
al lancio come K6-3D. Il processore è stato introdotto con tre diverse
combinazioni di frequenze interne ed esterne: 266/66, 300/100 e 333/95
Mhz; per l'estate arriverà la versione 350/100 e per fine anno
quella 400/100.
Il bus della versione a 333 MHz viaggia a una frequenza effettivamente
un po' anomala che è presente solo sulle ultimissime revisioni di
motherboard ma settandolo a 66, con l'alto rapporto 5:1, non darebbe prestazioni
molto migliori del 300/100. Questa soluzione si è resa necessaria
evidentemente perchè la resa attuale della produzione non arriva
ancora a buoni risultati a 350 e supera invece abbondamente su molti chip
le specifiche a 300 e la pressione di Intel sul mercato, che con il Pentium
II è già arrivata a 400 MHz, si fa sentire.
Sempre a proposito di bus c'è da notare che la versione a 266
Mhz conserva ufficialmente il bus a 66 Mhz ma deriva sempre dallo stesso
die e deve la sua classificazione inferiore quasi sempre a limiti sulla
qualità del core che non passa i test a 300. Ci sono quindi dei
settaggi alternativi da considerare, vista la forte incidenza sulle prestazioni
del bus esterno su cui lavora la cache L2: 250/100 conviene con la maggior
parte delle applicazioni che lavorano con molti dati in memoria; 263/75
va in ogni caso meglio della frequenza ufficiale così come per il K6
standard a 233/66 è preferibile usare 225/75.
Per quanto riguarda il supporto delle motherboard non ci sono particolari
problemi visto che il K6-2 lavora sempre con il core a 2.2V e l'I/O a 3,3V
come il precedente K6 model 7 a 0.25 micron (il K6 originale a 0.35 micron e 2.9 o
3.2 Volt è identificato come model 6); può solo essere necessario
aggiornare il BIOS per un corretto riconoscimento del processore, sopratutto
sulle schede dotate di settaggi automatici o comunque via software.
In ogni caso, come da buona abitudine di AMD, sul package sono sempre riportati
tutti i parametri fondamentali, descritti poi dettagliatamente sul datasheet
disponibile per il download online in formato pdf.

Se non conoscete il produttore della vostra motherboard è spesso
possibile scoprirlo tramite la lunga sigla in basso a sinistra all'avvio
del PC: trovate tutte le informazioni sui siti Award
e Wim's BIOS Page.
Ecco comunque una tabellina riassuntiva sui K6 model 6 e 7 e sul K6-2, come
integrazione del mio precedente
articolo sulla configurazione Socket 7.
| Processor |
Core Frequency |
Core Voltage |
I/O Voltage |
Bus Speed |
Clock Multiplier Pins |
| AMD-K6®- 2/333 |
333MHz |
2.2V |
3.3V |
95MHz |
3.5x (BFO=high,BF1=high,BF2=high) |
| AMD-K6-2/300 |
300MHz |
2.2V |
3.3V |
100MHz |
3x (BFO=high,BF1=low,BF2=high) |
| AMD-K6-2/266 |
266MHz |
2.2V |
3.3V |
66MHz |
4x (BFO=low,BF1=high,BF2=low) |
| AMD-K6/300 |
300MHz |
2.2V |
3.45V |
66MHz |
4.5x (BFO=low,BF1=low,BF2=low) |
| AMD-K6/266 |
266MHz |
2.2V |
3.3V |
66MHz |
4x (BFO=low,BF1=high,BF2=low) |
| AMD-K6/233 |
233 MHz |
3.2V |
3.3V |
66MHz |
3.5x (BF0=high,BF1=high, F2=high) |
| AMD-K6/200 |
200MHz |
2.9V |
3.3V |
66MHz |
3x (BF0=high,BF1=low, F2=high) |
| AMD-K6/166 |
166MHz |
2.9V |
3.3V |
66MHz |
2.5x (BF0=low,BF1=low,BF2=high) |
Dal punto di vista architetturale l'innovazione è rappresentata
dall'aggiunta di 3DNow!, 21 nuove istruzioni di tipo SIMD (Single Instruction
Multiple Data) principalmente per dati di tipo floating point, ma anche
per dati interi, fra le quali una specifica per l'altrimenti pesante decodifica
MPEG.
Il principio alla base di questa tecnologia è lo stesso del
precedente MMX, con nuove istruzioni specifiche che operano in parallelo
su più dati, ma sopratutto floating, molto usati nelle elaborazioni
3D; quindi 3DNow! si può considerare un'estensione di MMX e non
un suo sostituto. Anche Intel infatti prevede di rilasciare un proprio
set di istruzioni simile, denominato MMX2, che verrà però
incorporato nelle varie famiglie di microprocessori solo a partire dal
1999.
Il vantaggio temporale ha quindi permesso ad AMD di ottenere un buon
supporto da parte dei produttori di software, necessario per avere incrementi
prestazionali; diversi importanti produttori di giochi, stimolati dalle
potenzialità della tecnologia, stanno per rilasciare titoli con
motori 3D ottimizzati o patch per quelli già sul mercato: trovate
molte informazioni anche sullo stesso sito AMD.
Inoltre il nuovo standard è supportato dalle prossime imminenti
versioni, adesso in beta, delle due più importanti API 3D: OpenGL
1.2 e Direct3D di DirectX 6. In questo modo le tante applicazioni che fanno
uso di queste librerie trarranno vantaggio immediatamente senza bisogno
di nessuna modifica.
Anche i nuovi driver delle principali schede grafiche includono modifiche
per ottenere un'interazione ottimale con la CPU e fra questi quello della dominante
famiglia 3DFX Voodoo con la sua API 3D proprietaria Glide, usatissima dai
giochi 3D.
I primi risultati ottenuti con Quake II e 3D Winbench 98 sono notevoli,
il K6-2 quasi raddoppia le prestazioni del K6 e sopratutto supera a pari clock
il Pentium II con la sua avanzata FPU, ma a un costo decisamente inferiore; un
vero must per gli appassionati di giochi di azione con un occhio al portafoglio.
Intel Celeron e 440EX
All'estremo opposto si posizionano invece la CPU Celeron e il chipset
440EX, le offerte di fascia bassa Intel per l'emergente mercato dei PC
a basso costo; in realtà questi due prodotti sembrano solo
un ripiego del marketing e rappresentano un assurdo tecnologico per cui sono
stati criticati da tutta la stampa tecnica e per fortuna poco adottati dai costruttori.
Sarebbe stato più serio come soluzione temporanea abbassare semplicemente
il prezzo del Pentium II 233, calando il ricavo. Intel poteva anche facilmente
portare avanti la più economica piattaforma Socket 7 con Pentium MMX a frequenze
più elevate invece di tentare di sopprimerla per tagliare le gambe ai
concorrenti: non a caso per i portatili, dove ha il monopolio quasi assoluto,
ha portato la frequenza fino a 266 Mhz con la serie Tillamook.
Il Celeron non è altro che un chip Pentium II standard, della
più recente serie a 0,25 micron che è usata nelle CPU a partire
dal 333 MHz, senza i chip della cache L2 sulla schedina e persino privo
dell'involucro con il dissipatore per ridurre al massimo il costo.
La cache di secondo livello, che sui Pentium II lavora a metà
frequenza rispetto al core su un bus dedicato, è però uno
dei fondamenti dell'architettura ed infatti gli effetti sulle prestazioni
sono disastrosi: il Celeron a 266 Mhz nei normali benchmark applicativi
sotto Windows 95 va peggio di un normale Pentium MMX 233, che è
già decisamente più lento dei K6 di pari clock. Solo adesso
che il Pentium II 233 è andato fuori produzione è uscito
un Celeron a 300 Mhz che ne avvicina le prestazioni; viene
da pensare che il core tenga frequenze più alte e che il clock commerciale
sia solo dettato dal marketing attento ad evitare sovrapposizioni e massimizzare
i profitti.
Così come il Pentium II, con software completamente a 32 bit guadagna
un po' sul Pentium (ma non sul K6), e mantiene invece un certo margine
nei calcoli in virgola mobile grazie alla FPU avanzata.
In ogni caso il Celeron, con il suo controller e backside bus per la cache L2 inutilizzati,
rimane un campione di inefficienza architetturale senza pari, e, visto il costo non
bassissimo, anche il rapporto prezzo/prestazioni non è certo brillante.
Dopo l'estate uscirà la vera soluzione pensata per il basso costo, il nuovo core 'Mendocino'
con 128 KB di L2 cache a clock pieno integrati direttamente nel chip, con frequenze
iniziali di 300 e 333 MHz; verrà sempre venduto con il nome Celeron per Slot 1 e in seguito
sarà anche disponibile su un nuovo socket a 370 pin.
Assurdo nell'assurdo è la specifica sul bus esterno a 66 Mhz
visto che il core è lo stesso dei Pentium II con il bus a 100 e con la
mancanza assoluta della cache di secondo livello una velocizzazione della RAM
porta un certo miglioramento; schede madri permettendo, per guadagnare qualcosa
in prestazioni è quindi decisamente consigliabile configurare il Celeron 266
a 263/75 o 250/100 e il 300 ovviamente a 300/100.
A rendere problematico questo accorgimento c'è però il
differente sistema d'aggancio della CPU alla scheda madre; pur condividendo
il medesimo pinout Slot 1 infatti, il Celeron con la sua nuda schedina
denominata SEPP (Single Edge Processor Package) e il Pentium II con la
sua ben più grossa cartridge SEC (Single Edge Contact) hanno forma
e dimensioni diverse e incompatibili per i fermi. A meno di non usare quindi
il Celeron inserendolo solo nel pettine dello Slot 1 (che peraltro offre
una certa presa), senza però fissarlo stabilmente, o di non avere
una delle poche nuove motherboard con doppi meccanismi di aggancio bisognerà
comprarne una apposita: un vero inno all'inefficienza e al consumismo.
Oltretutto nelle intenzioni di Intel tali schede madri dovrebbero usare
il nuovo chipset 440EX, una sorta di 440LX semplificato, ancor più
assurdo del Celeron e da evitare assolutamente per non ritrovarsi con un
sistema poco espandibile e obsoleto in brevissimo tempo.
Se la rinuncia al supporto per la RAM di tipo ECC e al supporto multiprocessore
sono irrilevanti per il tipo di mercato a cui è destinato, altrettanto
non si può dire per i soli tre slot PCI ma sopratutto per i soli
2 DIMM. Oggi che anche schede audio e modem (che poi non ne avrebbero bisogno
per le prestazioni) stanno migrando dal bus ISA, 3 slot sembrano
pochini, basta aggiungere una scheda di rete e non c'è posto per
una 3DFX o un controller SCSI.
La limitazione sui DIMM invece è veramente irritante, sembra
fatta apposta per limitare gli upgrade. Considerando i costi di sviluppo
sarebbe sicuramente costato meno mantenere semplicemente in vita il vecchio
LX, non sono certo poche migliaia di porte logiche su un componente a bassa
tecnologia a fare differenze di prezzo oggi; non voglio poi nemmeno pensare
che il chipset EX sia solo un LX con alcune funzionalità disabilitate,
sarebbe in effetti economicamente vantaggioso ma anche una presa in giro per
gli utenti.
Hard Disk IDE
Veniamo invece adesso a un settore in cui la sana concorrenza porta
a continui miglioramenti di prestazioni e abbassamento dei prezzi e un
costo per Mega Byte in caduta libera.
Cominciamo da Quantum, che ha da poco introdotto l'ennesima evoluzione
della fortunata famiglia Fireball. Il nuovo modello, successore del vecchio
SE, è stato denominato EL, disponibile nella sola interfaccia Ultra
ATA, nei tagli da 2.5, 5.1, 7.6 e 10.2 GB. Le specifiche tecniche riportano
i soliti 9.5 ms come tempo di ricerca e 5.56 ms per la latenza media data dai
5400 RPM. Come sempre invece incrementano insieme la densità dei
dati, dai 2.1 GB dell'SE a 2.5 GB per piatto, e il transfer rate
interno, quello massimo passa da 158 a 162 Mbit/s. Gradita novità
invece è l'aumento del buffer, prima solo 128 KB, e adesso finalmente
512 KB, come il vecchio leader fra i dischi IDE, il sempre ottimo IBM Deskstar
8, alias DHEA, disponibile nei tagli da 4.3, 6.4 e 8.4 GB.
Così come fra gli HD SCSI si è assistito a una migrazione
per i modelli di punta al mostruoso regime di 10000 RPM, analogamente
fra gli IDE si sta passando da 5400 a 7200 RPM, con nuovi accorgimenti
tesi a minimizzare i problemi di dissipazione termica e affidabilità
a costi contenuti, requisito necessario per competere nel mercato di massa.
Prima ad arrivare sul mercato è stata Seagate con i nuovi Medalist
Pro ST34520A, ST36530A e ST39140A, rispettivamente da 4.5, 6.5 e 9.1 GB.
I dischi sono caratterizzati dai soliti 9.5 ms in ricerca, solamente 4.17
ms di latenza media grazie ai 7200 RPM, un buffer da 512 KB, 2.25 GB per piatto,
un transfer interno massimo di 194 Mbit/s e un effettivo transfer sustained
medio di 10 MByte/s. Da notare che per contrastare calore e rumorosità
generate dall'alto regime e migliorare l'affidabilità Seagate ha
impiegato un motore a bagno in uno speciale fluido.
Recentemente invece è arrivata puntuale la risposta IBM con
i nuovi Deskstar 14GXP, alias DTTA-37xxxx, con 9.5 e 4.17 ms per i
tempi di accesso, fino a ben 3.2 GB per piatto e con il transfer interno massimo
che passa da 127.4 del Deskstar 8 a 174.4 Mbit/s e un effettivo transfer sustained
che sale da 8 a 13 MByte/s.
Fate attenzione a non confonderlo con il prossimo arrivo per la fascia
media, il Deskstar 16GP, siglato DTTA-35xxxx, da 3.2 a 16.8 GB, 5400 RPM
e transfer poco minori.
Non pensate comunque che i 7200 giri da soli siano un toccasana miracoloso
per le prestazioni, l'unica conseguenza automatica è il calo della
latenza media di quasi 1.5 ms, i costosi HD SCSI di fascia alta impiegano comunque
meccaniche molto più sofisticate con tempi di ricerca di soli 5-7
ms. Anche i vari transfer rate, che comunque ai livelli odierni sono molto
meno importanti dei tempi di accesso, non aumentano automaticamente con
la velocità di rotazione. Le testine magneto-resistive infatti hanno
dei precisi limiti di velocità relativa rispetto ai dati sul disco
e al salire del regime si devono impiegare densità minori dei dati.
Per convincersene basta esaminare i dati degli IBM Deskstar DTTA: quelli
da 5400 RPM hanno una densità di registrazione di 193.9 KBPI mentre
quelli da 7200 RPM solamente 176.4 KBPI, le densità di traccie sono
entrambe di 13700 TPI quindi quello che cambia è la densità
dei dati lungo la traccia circolare seguita dalla testina. Il risultato dei
due effetti contrastanti è un piccolo vantaggio di transfer per il
14 GXP dato o da una testina leggermente più sofisticata o da semplici
motivi di marketing per distinguere meglio i due modelli.
Per finire auguro buone vacanze a tutti e vi do l'appuntamento a dopo
l'estate per un'altra serie di novità e consigli.
__________________________________________
BIBLIOGRAFIA E RIFERIMENTI
Vi segnalo che la mia pagina con l'indice dei siti internet dei costruttori di
hardware non è più raggiungibile al vecchio indirizzo ed è
invece adesso disponibile su
http://village.flashnet.it/~nenand/links-hw.html
e http://www.beta.it/group/a_nenni/links-hw.html.
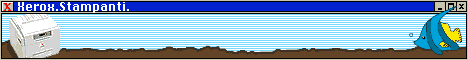
Andrea Nenni è articolista di BETA dal primo numero
ed è raggiungibile su Internet tramite la redazione
oppure all'indirizzo a.nenni@beta.it.
Copyright © 1998 Andrea Nenni, tutti i diritti sono riservati.
Questo Articolo di BETA, insieme alla Rivista, è distribuibile secondo i termini e le
condizioni della Licenza Pubblica Beta, come specificato nel file
LPB.
BETA Rivista |
Copertina |
Sommario |
InternetID |
Informazioni |
Browser
BETA Sul Web: http://www.beta.it
|

|