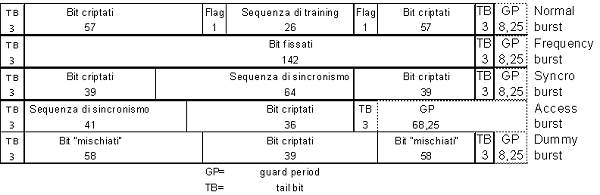|
BETA 2199.4 - Telecomunicazioni e Reti: L'interfaccia radio nel GSM (parte 1 | parte 2) - Indici | Guida | |||
|
L'interfaccia radio nel GSMParte 1 > Parte 2
Claudio Zito Introduciamo adesso qualche concetto fondamentale per poter poi entrare nel dettaglio sull'interfaccia radio e le sue problematiche. Definizione di canale radio La portante modulata occupa una ristretta regione dello spettro intorno alla frequenza della portante nominale. L'ampiezza di banda occupata, misurata in kHz è definita canale radio. Rumori ed interferenze Un canale radio di un sistema radiomobile può essere degradato da due cause:
Il rumore risulta essere costituito da fenomeni ambientali come i fulmini ad esempio, e da cause come i motori elettrici. Il rapporto segnale/rumore S/N è un parametro importante per la misura della qualità di un segnale RF. Per ciò che concerne l'interferenza possiamo dire che ne esistono di due tipi:
L'interferenza da canale adiacente si verifica quando due canali operanti su frequenze ravvicinate finiscono con il sovrapporsi, anche se solo parzialmente. L'interferenza co-canale si presenta invece quando due SRB in visibilità elettromagnetica operano contemporaneamente sulla stessa frequenza. In tal caso la MS sintonizzata su quella frequenza, potrebbe arrivare a sentire entrambe le portanti con la stessa potenza e quindi ricevere messaggi errati. Cammini multipli Un fascio di onde elettromagnetiche può essere riflesso da ostacoli interposti sul suo cammino. Nel caso di un ambiente radiomobile tale fenomeno viene definito cammino multiplo. La propagazione per cammini multipli, crea i seguenti svantaggi:
Diffusione ritardata (delay spread) A causa dei diversi cammini, i segnali multipli arrivano l'uno rispetto all'altro con dei ritardi differenti. Tale fenomeno provoca un effetto di frantumazione del segnale. La diffusione ritardata, ha dei valori fissi che dipendono dalla frequenza. Delle prove hanno mostrato che operando a 900 MHz un tipico valore misurato in ambienti chiusi risulta essere di 1 ms. Rayleigh fading Supponiamo che ad una MS arrivino solo due segnali e.m. trasmessi dalla BTS con cui sta dialogando. Uno arriva in maniera diretta e l'altro arriva da una riflessione. Se la fase del segnale riflesso è opposta a quella del segnale diretto l'informazione ne sarà fortemente degradata, o nella peggiore delle ipotesi sarà nulla. Quello appena descritto è un tipico esempio di fade del tipo di Rayleigh. Questo tipo di fade è detto anche veloce. Fade lento Se una MS spostandosi si avvicina a degli ostacoli di grosse dimensioni, questi possono riflettere il segnale creando così una zona d'ombra. In questa condizione l'inviluppo del segnale ricevuto varia relativamente lentamente, da cui il nome del tipo di Fade. Effetto Doppler Il continuo spostarsi delle MS rispetto alle BTS provoca, in sede di ricezione, un vero e proprio spostamento della frequenza di ricezione, questo effetto è detto comunemente Doppler. Se una MS che si trovi in conversazione si sposta alla velocità di 50 km/h, la compensazione Doppler media è di circa 30 Hz. GSM La standardizzazione del GSM ha fatto sì che in qualunque paese esso sia implementato lavori con la banda 890-915 MHz per la comunicazione tra MS e BTS (Uplink) e 935-960 MHz per la comunicazione tra BTS e MS (Downlink). Il sistema GSM è ad accesso ibrido, nel senso che utilizza una combinazione delle tecniche di multiplazione a divisione di frequenza (FDMA) e di tempo (TDMA) per la gestione della risorsa radio. Il codificatore vocale Dato che il GSM è un sistema digitale, la voce, che è interamente analogica, deve essere digitalizzata. Poiché il sistema veniva a inserirsi in una struttura di rete fissa in parte preesistente come PSTN e in parte in espansione come ISDN il metodo scelto doveva essere compatibile con la modulazione PCM da essi utilizzata. I canali PCM generano una sequenza in uscita a 64 Kbit/s. Mantenere una tale velocità usando canali radio come mezzo trasmissivo implica un notevole sforzo in termini di risorse hardware e di allargamento della banda occupata dal canale. Dato che il segnale vocale contiene una grande ridondanza, si sono studiati diversi algoritmi di codifica per raggiungere un compromesso tra qualità del servizio e difficoltà di realizzazione. Alla fine le specifiche richieste sono:
Dopo accurati studi, la struttura scelta è stata quella di un codificatore a tre stadi LPC-LTP-RPE (Regular Pulse Excited - Linear Predictive Coder - Long Term Predictor loop) in grado di fornire una qualità di poco inferiore a quella dello standard PCM. Tale codificatore è in grado di sfruttare sia le correlazioni di breve periodo tra campioni successivi del segnale vocale (filtro LPC), sia quelle tra segmenti di parlato adiacenti (filtro LTP). Il principio di funzionamento si basa sulla predizione dei campioni attuali dalle informazioni contenute nei campioni precedenti. La differenza tra il campione predetto e quello vero rappresenta il segnale da trasmettere. La voce è divisa in campioni di 20 ms, ognuno dei quali è codificato in blocchi di 260 bit, per una velocità di 13 Kbps. Modulazione Il segnale digitale viene modulato sulla frequenza portante utilizzando il metodo Gaussian Minimum Shift Keying (GMSK). Questo metodo consiste nell'associare ad ogni simbolo binario (0 e 1) una frequenza. Ad esempio, associamo la f(0) al simbolo 0 e la f(1) al simbolo 1. Quando in ingresso al modulatore si presenta uno 0 verrà inviata la f(0), mentre se si presenta un 1 viene trasmessa la frequenza f(1). Per diminuire l'ampiezza dello spettro di frequenza si sceglie di utilizzare due frequenze con uno sfasamento pari a 180Ý. Così si garantisce la continuità di fase nelle transizioni da un simbolo al successivo. Per ridurre ulteriormente i lobi laterali del segnale modulato s'introduce un filtro passa bassa prima del modulatore. Equalizzazione La lunghezza d'onda del GSM è di circa 17 cm. Per simili onde gli ostacoli non vengono attraversati ma fanno rimbalzare le onde. Questo implica che in ricezione una antenna può captare molti segnali riflessi, ognuno con una fase differente. L'equalizzazione è usata per separare il segnale desiderato dalle riflessioni spurie. Il segnale codificato viene sempre trasmesso nei 26 bit riservati appositamente in ogni burst period. Così l'equalizzatore può cercare di scoprire come il segnale è stato modificato dal percorso, e quindi "costruire" un filtro inverso per estrarre la parte del segnale in massima verosimiglianza al segnale originario. Multiplazione FDMA e riutilizzo delle frequenze La tecnica FDMA divide l'ampiezza di banda di 25 MHz in 124 frequenze portanti spaziate di 200 KHz ciascuna di cui è definita come: FUplink(n) = 890.2 + (n - 1) * 0.2 [MHz] FDownlink(n) = FUplink(n) + 45 [MHz] Nei paesi in cui sono presenti più gestori di rete, es. TIM e OMNITEL, le frequenze portanti sono divise tra i vari operatori. In Italia la frequenza 77 (905.4 MHz, 950.4 MHz) è volutamente non assegnata, perché usata come una barriera tra le bande dei due operatori (guard channel). In Italia, inoltre, la situazione è complicata dalla compresenza del sistema analogico E-TACS, che usa la banda dei 900 Mhz così: uplink 880.0125 - 896.7875 MHz downlink925.0125 - 941.7875 MHz Multiplazione TDMA Ogni singola portante viene suddivisa nel tempo, secondo la tecnica TDMA, in 8 intervalli (time slot) della durata di 577 µs e l'insieme di 8 time slot, della durata di 4,616 ms, viene definito trama o frame. Il time slot k-esimo di ogni trama della i-esima portante costituisce un canale, in tutto sono 992. I canali di traffico propriamente detti sono organizzati in base a gruppi di 26 trame, quelli di controllo in base a gruppi di 51 trame. Questi gruppi costituiscono una multitrama (multiframe). Le due multitrame di durata rispettivamente 120 ms e 235,4 ms sono inserite in una supertrama (superframe) di 6.12 s che contiene rispettivamente 26 e 51 multitrame (per un totale di 1326 trame) unificando la struttura delle trame gerarchicamente inferiori. A loro volta 2048 superframe formano una ipertrana (hyperframe) composta di 2715648 trame numerate progressivamente (frame number, FN) e in modo ciclico su una periodicità di 3 ore, 28 minuti, 53 s e 760 ms. In definitiva un canale fisico è identificato da tre coordinate: dal proprio numero di time slot (TS), di trama (FN) e di frequenza portante. Nel caso che il frequency hopping sia attivo il canale sarà definito più esattamente da una traiettoria temporale in cui il time slot scorre da una frequenza all'altra. Per semplificare l'hardware delle MS in modo da non avere simultaneamente trasmissione e ricezione, i canali di uplink e downlink sono separati nel tempo da 3 time slot. Così una MS che riceva nel time slot Tk della portante Fi MHz, ritrasmetterà nel time slot T(k+3) sulla frequenza Fi - 45 MHz, nei restanti 6 time slot può così ascoltare gli altri canali che riesce a ricevere, così se c'è un interferenza co-canale si sente e nel frattempo ascolta e mette in lista le frequenze delle BTS adiacenti per un eventuale handover.
Il numero totale dei canali fisici disponibili risulta essere di 992 da distribuire all'interno del cluster di celle. Ad essere esatti attualmente i canali della banda GSM 900 sono 992, ma quando dalla codifica full rate si passera alla codifica half rate tale numero raddoppierà (1984). I canali logici devono essere inseriti "fisicamente" nella struttura TDMA. Un canale logico viene associato ad un time slot di una frequenza su cui si alterna con gli altri canali nella successione delle trame, possiamo allora dire che il canale fisico è definito come un intervallo di tempo i-esimo in cui si sta utilizzando la portante k-esima, a seconda dell'utilizzo di questo intervallo di tempo avremo dei canali voce o dei canali di segnalazione. Al canale di segnalazione BCCH è di norma riservato il time slot 0 di una sola delle frequenze assegnate ad una cella in entrambe le direzioni. Tale frequenza prende il nome di portante fondamentale o portante BCCH, e spesso la si trova indicata con C0. E' interessante notare che i canali di segnalazione che consentono "l'aggancio" alla rete ad una MS sono tre: FCCH, dove si trasmette la portante; SCH dove è inviato il numero di trama che si usa poi negli algoritmi di frequency hopping; BCCH dove si trasmettono i System Information relativi alla BTS dove si trova la MS. Questi canali esistono solo nella direzione downlink e ovviamente non sono soggetti al frequency hopping. Caratteristiche dell'interfaccia radio Un aspetto centrale di una rete che utilizzi l'accesso a divisione di tempo (TDMA) è quello della sincronizzazione. Poiché una MS può trovarsi ad una distanza dalla BTS che varia da circa 0 (sotto le antenne) al confine (35 km teoricamente) di cella il tempo che impiega il segnale modulato a percorre questo spazio è variabile. Questo aspetto dovuto alla propagazione del segnale potrebbe creare dei problemi se due time slot venissero a sovrapporsi temporalmente a causa del ritardo. Nel GSM per superare questo problema si adotta la tecnica dell'avanzamento temporale (timing advance), in base al quale la BTS ordina alla MS di anticipare l'inizio della sua trasmissione di un intervallo di tempo quantificato in modo tale da sopperire al ritardo di propagazione. Per far ciò, all'interno di ogni time slot una parte è lasciata libera. La parte non utilizzata vi è un cosiddetto periodo di guardia (gard period) che ha una durata corrispondente a 8.25 bit. I burst nelle trame L'informazione contenuta in 1 TS di una trama TDMA viene definita burst. Ci sono 5 differenti tipi di burst:
I 156.25 bit sono trasmessi in 0,577 ms, quindi con una velocità media di 270.833 Kbps. L'informazione è inserita il due blocchi da 57 bit a cui si aggiunge uno stealing flag per indicare se è il blocco contiene dati TCH oppure segnalazioni SACCH o FACCH. Le sequenze start e stop sono fissate a zero e servono a reinizializzare la memoria dell'equalizzatore di Viterbi. I 26 bit della sequenza di training rappresentano la sequenza utilizzata dall'equalizzatore per determinare i parametri dell'algoritmo di decodifica. Gli 8,25 bit finali non vengono effettivamente trasmessi, ma rappresentano un guard period durante il quale l'assenza di segnale consente un margine di sicurezza al fine di evitare sovrapposizioni tra burst appartenenti a time slot adiacenti.
Fig. 2 Struttura dei burst nel GSM Power Control La funzione di Power Control o controllo della potenza è obbligatorio per le MS perché così facendo oltre a diminuire le interferenze realizzano una maggior durata della batteria, mentre per le BTS è stata implementata solo nel 1998. L'utilizzo di questa funzione si basa sul principio che, MS vicine alla BTS, non hanno la necessità di trasmettere al massimo della potenza. Tale funzione si effettua in maniera indipendente, nelle direzioni uplink e downlink, per ogni canale logico e per ogni MS. Ovviamente il Power Control non si applica al BCCH per poter effettuare i confronti fra le varie portanti. Gli step di incremento e di decremento sono di 2 dB. Discontinuos Trasmission (DTX) La funzione DTX serve, nella rete GSM, a ridurre il valore medio delle interferenze. Mentre la MS è in conversazione, la portante radio viene inviata solo se il microfono del terminale percepisce un suono. Nei casi di silenzio la portante radio non viene inviata. Questa funzione si attiva sia per le MS che per le BTS mediante dei comandi di rete. E' però necessario che nei terminali sia presente un VAD (Voice Activity Detector), capace di riconoscere la presenza del parlato. Nella MS, la soppressione della portante radio determina un effetto sgradevole, sembra che non esista un interlocutore. Per ovviare a questo inconveniente si è introdotta la funzione di confort noise. In pratica la MS riconosce la condizione e genera verso il proprio auricolare un suono che simula localmente il rumore ambientale dall'altra parte del collegamento. Per minimizzare le interferenze tra canali attigui e risparmiare potenza, sia il terminale mobile sia la stazione base operano al valore minimo di potenza che assicura ancora una accettabile qualità del segnale (RxLev). La potenza di emissione del segnale sul canale radio può essere variata in modo dinamico su 16 livelli dal valore massimo per la classe di appartenenza al minimo di 13 dBm (circa 20 mWatt) a step di 2 dB. La MS misura l'intensità e la qualità del segnale, e trasferisce queste informazioni alla stazione base (attraverso il canale SACCH) che decide se e quando cambiare il livello di potenza. In particolare la BTS, tramite il parametro MSTxPrw, informa la MS della massima potenza che può utilizzare nella comunicazione. Discontinuos Reception (DRX) Con questa funzione le MS risparmiano molta dell'energia delle loro batterie. Si realizza in quanto la rete raggruppa le MS registrate in una data location area gestita da un BSC in paging group e prestabilisce l'invio di eventuali paging ai terminali di ciascun gruppo in determinati intervalli di tempo. In pratica poi ogni MS è in grado di determinare gli istanti di tempo nei quali potrebbe arrivare un messaggio destinato a lei. In questo modo, quando la MS è nello stato di riposo, il ricevitore si alimenta solo negli intervalli di tempo in cui potrebbe ricevere messaggi dalla rete. Il valore di DRX della rete è inviato in modo broadcast sul canale BCCH, ed è talvolta indicato con la sigla BS-PA-MFRM (Base Station-PAging-MultiFRaMe). E' un numero di 4 bit che esprime la distanza tra due messaggi di paging successivi sul canale PCH in multipli di 51 trame (Multiframe). Ogni Multiframe ha una durata di 235.4 ms, quindi un valore di DRX pari a 4 indica che i messaggi di paging verso una MS si susseguono ogni 235.4x4=941,6 ms. Frequency Hopping (diversità in frequenza) Consiste nel trasmettere messaggi successivi di una stessa comunicazione su frequenze portanti diverse, mantenendo però sempre lo stesso time slot assegnato inizialmente. Questa tecnica presenta due vantaggi:
Il parametro HSN indica il modo con cui le MS della cella devono "saltare". Esistono 64 differenti valori che può assumere HSN. Quando HSN vale 0 il FH è di tipo ciclico, tutti gli altri valori implementano salti pseudo-casuali. La lunghezza di un FH ciclico è funzione del numero di frequenze nella cella. Nella pratica si cerca di non usare questo valore. Con salti pseudo-casuali la sequenza è ripetuta circa ogni 6 minuti. Funzione di hand over A causa del riuso delle frequenze il raggio di estensione delle celle diminuisce, creando la necessità alla MS che si trova in movimento durante una conversazione di cambiare cella sempre più spesso. La possibilità di cambiare cella senza che la conversazione cada viene detta hand over. Nel sistema GSM questa procedura è realizzata mediante un interlavoro molto stretto tra MS, BTS, BSC ed MSC secondo il principio della logica distribuita, per distribuire il carico elaborativo richiesto dall'handover. L'handover viene effettuato in base ai risultati di alcune misure effettuate da MS e BTS. Poiché la MS impegnata in una conversazione rimane collegata con la BTS solo nei time slot ad essa dedicati nell'ambito della trama TDMA nei rimanenti time slot può effettuare le misure. Mentre la MS è in conversazione effettua la misura sul livello di potenza ricevuto (RXLEVEL radiomobile) e sulla qualità delle connessione (RXQUAL) effettuando una stima del BER (bit error ratio). Quando la MS si trova nei time slot che non le competono per dialogare con la BTS, poiché mediante i system information trasmessi sul canale BCCH è a conoscenza delle frequenze di BCCH delle sei BTS adiacenti, effettua misure sul livello di campo di queste celle (RXLEVNCELL). Dal canto suo, la BTS esegue le corrispondenti misure (RXLEV fisso, RXQUAL fisso) nel verso da MS a BTS. Inoltre valuta il timing advance (distanza tra MS e BTS) ed i livelli d'interferenza sui canali liberi. Ogni 480 ms la MS invia alla BTS sul canale SACCH i risultati delle sue misure. La BTS a sua volta li invia al BSC che li elabora e crea una lista di preferenza (rank list) delle celle che potrebbero essere in grado di servire la MS. Se la qualità della conversazione sul canale di traffico scende al di sotto della soglia prefissata, il BSC decide un handover scegliendo la BTS ed il canale di traffico secondo quanto visto nella rank list. La BTS che viene lasciata per handover subisce una "penalità" che ostacola il ritorno immediato ad essa. Le motivazioni principali che possono portare ad una richiesta di handover sono quattro:
In funzione delle celle interessate, l'operazione di handover può essere suddivisa in quattro tipi:
è un handover particolare in quanto consiste nel comandare ad una MS il cambio di del canale di traffico ma non di cella. Può accadere quando vi sia una bassa qualità del segnale (RXQUAL) mentre il segnale di ricezione (RXLEV) è accettabile, ma non viè alcun altra BTS che possa servire meglio la MS. in questo caso l'handover è gestito totalmente dal BSC che pilota la MS da una cella ad un'altra cella, e ne dà solo comunicazione al MSC/VLR da cui è gestito. in questo caso l'handover è pilotato dall'MSC/VLR che gestisce il BSC. è il caso più complesso, in quanto nel cambiare cella la MS cambia anche MSC/VLR e quindi deve variare l'istradamento della chiamata. L'MSC originale, detto anchor MSC, continua a rimanere responsabile della maggior parte delle funzioni relative alla chiamata in corso mentre gli handover interni (inter-BSC) che dovessero eventualmente verificarsi saranno gestiti dal nuovo MSC, detto MSC target. Dopo un handover può essere necessario aggiornare la localizzazione della MS (location updating). Distinguimo tre casi:
Copyright © 1999 Claudio Zito, tutti i diritti sono riservati. Questo Articolo di BETA, insieme alla Rivista, è distribuito secondo i termini e le condizioni della Licenza Pubblica Beta, come specificato nel file LPB. |
|
BETA 2199.4: Sommario | Indice del Numero | Redazione | Liste/Forum | Informazioni | Licenza Pubbl. Beta | Mirror ufficiali | Abbonati a BETA | Internet ID | Guida | Cerca | Stampa Copyright © 1994-1999 BETA, tutti i diritti sono riservati - http://www.beta.it |

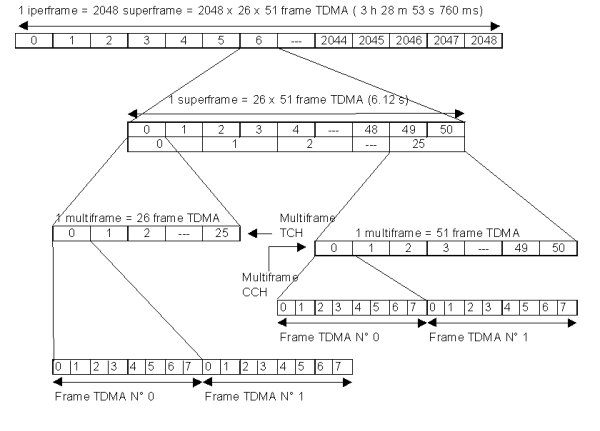 Fig. 1 Gerarchia di multiplazione trame nel GSM
Fig. 1 Gerarchia di multiplazione trame nel GSM